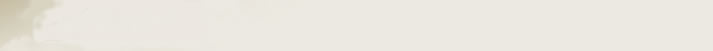Enrico Gambelli – “Lilith”
Oniemiserenuani, era in effetti un nome un po’ troppo lungo. Così all’età di 4 anni circa divenne per tutti Lilith. Più o meno in quel periodo Lilith era solita passare ore e ore sull’altalena costruita dal padre. Due corde legate ad un ramo di un mango e un copertone per sedile, proprio dove, come gli ricordava il papà, era caduta una bomba in pieno conflitto biafrano scuotendo le povere fondamenta del loro compound. A Lilith piaceva dondolare e fantasticare fino a sentire mal di pancia; aspettava così il ritorno a casa dei genitori sul loro vecchio maggiolino verde dal rumore inconfondibile. Con la vista saliva fin sopra i tetti di lamiera delle baracche fino a scorgere la strada di terra rossa che lambiva la foresta da dove prima o poi sbucava immancabilmente l’auto dei genitori. Un giorno di settembre aspettò invano. Gli adulti del villaggio le dissero cose brutte che forse neanche capì bene e tutto cambiò. La portarono a Lagos, durante le sedici ore di corriera non riuscì a pensare a nulla ne proferì parola. L’accolsero gli zii con i loro tre figli. Lilith trovò carezze, affetto, calore, ma non riuscì mai a sentirsi una della famiglia. In quella città tutto era smisurato e maledettamente difficile come attraversare una strada o salire su un autobus. Il frastuono assordante l’odore acre dell’aria,la calura opprimente: tutto era ostile. Eppure ci visse per più di dieci anni,andando a scuola e sopratutto aiutando la zia nel chioschetto ambulante di bibite e frutta secca. Accadde che nei giardini dinanzi alla scuola le presentarono Vik che gli propose di andare a lavorare in Italia. Non le nascose niente. Nei giorni successivi parlarono sopratutto di Madame Peace, di prestazioni, di possibilità di riscatto, di visti, di passaporti. Lilith per la prima volta decise per conto suo. Non si fece illusioni, pensava solo di cambiare vita, ne meglio ne peggio, solo una vita diversa.
Quando la polizia fece irruzione nell’appartamento di Madame Peace, Lilith stava pensando che era l’ora di prendere un tè con le altre ragazze mentre sopra di lei si dimenava un omino magro dalla carnagione bianchissima. Non poteva immaginare che non avrebbe più rivisto le sue amiche ne Madame Peace. Alla centrale, disse di avere poco più di 16 anni, la cosa lasciò un po’ interdette le poliziotte che la stavano interrogando, ma poi decisero di portarla presso il più vicino ospedale: l’esame radiografico del polso confermò l’età. Le dissero che era stata fortunata, essendo minorenne non poteva essere rimpatriata come le sue colleghe. Dopo un convulso giro di telefonate, malgrado l’ora tarda, l’accompagnarono presso una struttura di pronta accoglienza per minori.
Il tragitto fu brevissimo. Fu accolta con gentilezza da due operatrici della comunità, ma il loro inglese non era un granché; di ciò che gli dissero Lilith non capì che una minima parte. Comunque fece una doccia, prese un tè con i biscotti, indossò dei vestiti puliti. Poi le presentarono gli altri ospiti della struttura che per l’occasione avevano aspettato il suo arrivo fino a notte tarda: tre ragazzini afgani, un bambino curdo-iracheno e una ragazza turca. Le assegnarono una stanza con un solo letto al piano superiore. Lilith apprezzò la sobrietà e l’ordine che regnava nella piccola stanza: le pareti bianche, le lenzuola fresche e pulite su cui quella sera si addormentò come un sasso. I giorni successivi furono un susseguirsi di visite mediche, vaccinazioni, incontri con mediatori linguistici e assistenti sociali. Ci vollero diversi incontri prima che Lilith rispose più o meno esaurientemente alle domande poste sul suo viaggio in Italia e sui suoi familiari in Nigeria.
Contestualmente le venivano offerte alcune proposte: avrebbe avuto un permesso di soggiorno, avrebbe frequentato un corso di lingua italiana e di alfabetizzazione informativa, magari in seguito avrebbe anche potuto fare un tirocinio lavorativo in una pasticceria o in una lavanderia. Pian piano queste proposte cominciavano a frullargli in testa. Ci pensava sopratutto nelle prime ore del pomeriggio, quando dopo aver mangiato saliva in camera. In quelle ore in comunità regnava solitamente il silenzio e ciò gli trasmetteva una certa serenità d’animo; si stava lentamente insinuando la capacità di vedere le cose in una nuova ottica, pensando e progettando il suo futuro anziché subire gli eventi. I ragazzi afgani con cui manteneva un certo distacco erano molto educati e rispettosi. La ragazza turca e il bambino richiedevano molte attenzioni e assorbivano gran parte del tempo e del lavoro degli operatori. Questi chiedevano anche dieci volte al giorno a Lilith se stava bene e se avesse bisogno di qualcosa, quasi a giustificarsi del fatto che più di tanto non riuscivano ad interagire con lei. Ma l’unica cosa di cui aveva bisogno Lilith era fare ordine nella propria testa.
Erano passate circa quattro settimane dal suo arrivo; un pomeriggio di giugno un operatore stava giocando a calcio in giardino con il gruppo di ragazzi afgani che nel frattempo era cresciuto con nuovi arrivi. Stava pensando che era più facile insegnare loro la lingua italiana che non tirare calci al pallone, nella convinzione che mai in vita sua avrebbe visto l’Afganistan qualificarsi ai mondiali di calcio. Scorse Lilith dirigersi verso il confine del giardino delimitato da alti rovi e cespugli. Incuriosito la seguì con discrezione.
C’era una altalena, quasi mai usata dai ragazzi, era li che Lilith si stava dirigendo. Ci salì e iniziò a dondolare lentamente, poi si spinse sempre più in alto con le gambe lunghe e affusolate, le treccine erano leggermente mosse dal vento. Sopra i rovi si poteva scorgere una verde collina punteggiata da macchie rosse e gialle di papaveri e ginestre che scendeva dolcemente verso il mare. Ancora più giù il porto con i containers, le grandi navi ormeggiate e il placido scivolare delle barche a vela. Quel paesaggio difficilmente poteva passare inosservato. Quando l’operatore cautamente si avvicinò a Lilith gli sembrò che avesse gli occhi socchiusi. Forse stava fantasticando.
Martina Beretta – “Vaslij Dubcek”
Quando Don Vincenzo gli si avvicinò, d’istinto, fu assalito da un conato di vomito. Eppure non era la prima volta che percepiva quell’odore. Nel corso degli anni si era abituato a molte cose: alla vista del sangue o della pelle violata dai morsi, dalle bruciature, dalle cinghiate ma appena sentiva l’olezzo di sudore e d’urina misto a quello della putrefazione delle discariche non si poteva trattenere. Forse era una difesa istintiva, un segnale per rammentargli che non tutto doveva essere accettato, e che la dignità umana non poteva essere così umiliata. Si era imbattuto per la prima volta con quel tanfo quando aveva accompagnato alcuni agenti in una sorta di “campo” ai limiti della città dove si erano insediati alcuni rom. Poche tende stracciate e qualche asse smangiato costituivano le pareti delle abitazioni. Il putrido resto era sparso disordinatamente sul terreno: barattoli arrugginiti, cartoni sfasciati, resti di cibo, escrementi ma soprattutto topi, tantissimi topi che, fulminei, smuovevano dei cenci luridi come le facce di coloro che tentavano di fuggire. Quella volta era stato malissimo, aggrappato come un naufrago ad un tronco sbrecciato.
Solo l’appuntato Panzeri se n’era accorto e gli aveva consigliato di non muoversi e di aspettarli fuori, non ci avrebbero messo troppo. Proprio allora nella mente era apparso un terso ricordo da liceale: una frase letta quasi alla fine dei Promessi Sposi: “La disgrazia non è patire e l’esser poveri; la disgrazia è far del male”. Don Vincenzo pensò che lì la vera disgrazia era vivere.
Girò un poco la testa di lato per evitare che l’assistente sociale del tribunale dei minori se ne accorgesse. Prese il fazzoletto dalla tasca dei pantaloni se lo passò sulla fronte. Lo sguardo duro della donna rivelava i suoi pensieri: “Ma che razza di prete è mai questo? Fa anche lo schizzinoso dovrebbe vedere cosa ci capita. Si muovesse a firmare i documenti che li devo riportare in ufficio. Mio Dio com’è tardi! Ho paura di restare imbottigliata nel traffico… su, su, si muova”.
Mentre lei frettolosamente scendeva le scale di pietra esterne all’istituto, Don Vincenzo fissò lo sguardo sul ragazzo.
Vaslij era una sua vecchia conoscenza: lo aveva avuto in affido per circa sei mesi quando non doveva avere più di cinque, sei anni. Senza documenti, né fissa dimora, era stato abbandonato in un supermercato.
Allora, come adesso, era rimasto lì, fermo immobile, vicino ai grandi finestroni della sala comune senza dire una sola parola, a ciglio asciutto, gustandosi però il bagliore dei raggi del sole che attraversavano a lama le vetrate. Una magliettina penzolante su di un lato faceva intravedere l’omero minuto e fragile, mentre due gambette esilissime uscivano fuori dai pantaloncini lisi e puzzolenti. I capelli sottili di un castano opaco erano tagliuzzati malamente. Erano così ispidi che si erano appiccicati fra loro a ciocche che ora si ergevano ritte, ora si piegavano sulla sua testolina.
Ma al di là della generale incuria, ciò che colpì Don Vincenzo fu lo sguardo già precocemente smaliziato del bambino: questi era a tratti supplichevole, quasi implorante ma si alternava a dei guizzi di beffarda ironia proprio nei confronti di chi poteva provare pena per la sua condizione.
Non fu solo questo fatto a stupire il sacerdote: si accorse ben presto che il linguaggio del piccolo era scarno, ma non lo era certamente una curiosità felice verso tutto ciò che produceva suoni. Nell’aula di musica aveva trovato un vecchio violino e, spiando gli ospiti più grandi durante le lezioni, aveva iniziato a suonarlo, così a orecchio. La sua musica morbida, avvolgente lasciava negli animi una stupefatta meraviglia.
Il tutto però cessò bruscamente: Vaslij sparì in pieno giorno e solo verso sera ci si accorse di un buco strettissimo nel muro di recinzione.
Il piccolo era una merce troppo preziosa per restare inutilizzata: cencioso e affamato finì per strada ad agitare uno smangiato bicchiere davanti ai passanti. Così Don Vincenzo ne perse le tracce e ora, per disposizione del giudice, era lì a “scontare in un ambiente protetto la pena detentiva dei mesi nove per borseggio”. Non era cambiato granché a parte una crescita irregolare di chi doveva fare i conti con pasti saltuari. Come tutti coloro che si erano formati senza alcuna regola e tantomeno avevano badato a rispettarne altre, Vaslij possedeva la supponente arroganza di chi poteva permettersi di violare le norme senza alcun rimorso né fastidio. Anzi, da questo ne traeva un sottile e perfido piacere perché gli arrecava un senso d’inebriante superiorità.
I giorni dopo il suo arrivo furono terribili: l’equilibrio già precario delle difficili personalità degli ospiti fu fortemente turbato dalle strategie puntigliosamente pianificate dal ragazzo. Pungente o supplicante a seconda dei casi, fine osservatore dei caratteri altrui, conosceva le debolezze di chiunque e le adoperava a suo vantaggio. Come un flessuoso incantatore manipolava tutti coloro con cui veniva in contatto per il mero gusto di dimostrare e imporre la sua volontà.
Solo la musica aveva su di lui un influsso positivo e rivestiva un ruolo privilegiato: la trasformazione era visibile appena prendeva in mano il suo violino. Creativo come un istrionico interprete faceva vibrare le corde dell’anima alla stessa maniera di quelle del suo strumento. Per Don Vincenzo questo parve un buon punto da cui partire. Aveva un carissimo amico al Conservatorio che aveva acceso un progetto per altri ragazzi Rom. Si trattava di mandarlo a lezione per regolare e sviluppare oltremodo la sua innata capacità.
Gli incontri erano di sabato e Vaslij accettò questo sacrificio. Inserito nella sezione dei violini impiegò poco tempo ad affinare la tecnica giungendo ad interpretare brani impegnativi con disarmante naturalezza. Il suo maestro ne era entusiasta. Raramente aveva avuto modo di essere a contatto con una personalità così spiccata e recettiva.
Da quel momento l’attività musicale sembrò assorbire pienamente il ragazzo che dimostrò una costanza inaspettata. Visto gli esiti non gli si poteva negare il posto di primo violino al concerto finale. Quella sera Vaslij era eccessivamente turbato: era smanioso di una strana inquietudine che a tratti poteva dirsi spavento. Don Vincenzo lo osservava con apprensione e si era dato come unica spiegazione possibile l’eccessiva responsabilità legata all’evento, esperienza del tutto nuova per l’animo del giovane. Conoscendone l’indole, il sacerdote temeva comunque una sparizione e per questo gli aveva affiancato due volontari del centro che ne seguivano le mosse.
L’adolescente però non mancò al concerto e fu un trionfo: il suo. Fu struggente e delicato, leggero e sicuro e la prestazione fu senza dubbio di altissimo livello. Frastornato dagli applausi e dalle ovazioni chiese ai suoi accompagnatori di assentarsi un attimo: doveva andare in bagno.
Sull’autobus di ritorno il suo posto rimase desolatamente vuoto.
Dopo pochi mesi, Don Vincenzo sfogliando il giornale venne attratto dalla notizia di una rapina avvenuta poco lontano da lì e finita male: un giovane malvivente era stato ucciso durante lo scontro a fuoco con le forze dell’ordine. Non ebbe alcuna difficoltà a riconoscerlo. Era Vaslij Dubcek di anni sedici.